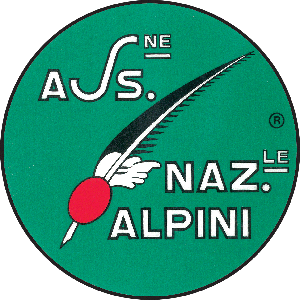Storia dei Nostri Reduci
In questa sezione vogliamo dare vita alla rubrica de “I nostri reduci”: tante storie di vita militare, che non vogliamo vadano perse. Purtroppo molti sono i reduci che ci hanno abbandonato; non lasciamo che “vadano avanti” anche tutti gli altri prima di averli ascoltati e perché no,anche intervistati.
Facciamo appello quindi a tutti gli alpini della Sezione per collaborare a questa nuova rubrica.
Primo Biolzi
Nato a Vianino di Varsi il 20 marzo 1915, fu arruolato nell’8° reggimento Alpini, battaglione Gemona nel ’36 e subito congedato.
Richiamato nel maggio del ’40 nel battaglione “Val Fella” dell’8° rgt. della “Julia” fu inviato sei mesi dopo in Albania, col reparto salmerie.
Dal marzo ’41 partecipò alle operazioni di guerra fino al 28 luglio ’42, quando fu rimpatriato via terra per ripartire per la Francia il 20 novembre con il Gruppo Alpini “Valle”.
Rientrato in Italia nel gennaio del ’43, rimase sbandato dopo l’armistizio dell’8 settembre fino al 25 aprile ’45, quando la provincia di Parma venne liberata.
Il 1° settembre successivo sarebbe stato finalmente e definitivamente congedato.
Primo oggi vive a Milano ma d’estate torna a Bettola di Varsi e racconta personalmente i dettagli della sua lunga vita militare, e non solo, nel video dell’intervista rilasciata a Bernardino Moruzzi, visibile qui.
Livio galli
Nato a Pessola di Varsi l’11 ottobre 1913, fu arruolato nel 14° reggimento, 2° battaglione, della divisione Pinerolo nel 1936 dove fu trattenuto per tre anni a causa della guerra d’Africa.
Richiamato nel 1940 fu inviato in Albania dove partecipò a tutte le operazioni di guerra della divisione come portaferiti.
L’8 settembre 1943 fu fatto prigioniero dai tedeschi e trasferito dalla Grecia in un campo di prigionia in Germania.
Dopo varie vicissitudini fu trasferito nella periferia Dresda dove poté assistere al tragico bombardamento della città nella notte fra il 13 e il 14 febbraio 1945.
Finalmente liberato dall’esercito russo, attraverso Innsbruck e Trento tornò al suo paese nel luglio del ’45.
Il video dell'intervista è visibile qui.
Carlo Mori
Una rappresentanza del Gruppo Alpini di Collecchio, con gagliardetto, formata da Sergio Torta e da Maurizio Donelli ha presenziato alla consegna della Medaglia d’onore dedicata agli Internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943.
La cerimonia ha avuto luogo a Praticello di Gattatico (RE); in questo paese è residente l’ultimo Reduce del Gruppo di Collecchio, Carlo Mori (cl. 1920), Artigliere da montagna combattente sul fronte greco - albanese, con il fratello Otello (quest’ultimo “andato avanti” qualche anno fa).
Era presente una folta schiera di Autorità civili e militari, fra cui il Ministro Adriano Poletti ed il Sindaco di Praticello Gianni Maiola.

Adriano Chiappa
Ci manda un video messaggio dal lontano Canada l’Alpino Adriano Chiappa, un giovanotto nato il 10 settembre del 1923 ed emigrato nel ’59 a Ottawa. La figlia Anna ci ricorda che il padre Adriano entrò nella caserma Cantore nel lontano 1943 a Tolmezzo del Friuli, a due passi dal confine austriaco. Pubblichiamo questo suo messaggio, riconoscendogli la sua appartenenza alla nostra provincia, visto che è nato a Pilati di Scopolo, una piccola frazione di Bedonia, vicino alla provincia piacentina. Adriano è un Alpino tosto e con sè, nel lontano Canada, si porta la sua alpinità, fornendo il suo contributo all’interno del Gruppo cittadino, fino all’elezione a Presidente, che ha mantenuto per parecchi anni. Tra i suoi prestigiosi risultati, ricordiamo volentieri la creazione di un Monumento a tutti i Soldati Caduti di tutte le Guerre. Si sposa con una sua compaesana, Maria Oliva Draghi di Illica, una frazione di Bedonia e insieme hanno avuto tre figli e sono nonni di due nipoti. Postiamo volentieri questo racconto per rimarcare, come se ce ne fosse bisogno, quanto abbia segnato nei giovani l’appartenenza a un corpo militare come quello degli Alpini e per quanto tempo questi segni rimangano indelebili.
Mario Ortalli

“Mi alzo, mi vesto, mangio un boccone e mi incammino verso il bosco dove c’è la catasta di legna. Mentre con lena faccio scorrere la sega, dalla strada una figura conosciuta mi chiama. È il maresciallo. Mi avvicino, ci salutiamo e lui con garbo e gentilezza mi consegna il talloncino e mi augura un felice avvenire. Mia madre non ha parole! Già tre fratelli sono sotto le armi; sperava che io non fossi chiamato, sperava di aver già dato figli a sufficienza per il valor patrio, ma non è così. Si parte. Una pagnotta di pane, un pezzo di formaggio e un mezzo salame; tutto è troppo, serve anche per quelli che rimangono. Alla stazione di Fornovo trovo altri giovani di Bardi, Solignano, Valmozzola e di altri paesi pronti a partire. Il treno parte, il cuore è gonfio e gli occhi sono lucidi: lasciamo tutto il nostro mondo e andiamo incontro al destino. Lo stridore dei freni ci fa capire che siamo arrivati nella stazione di destinazione: Udine. Un camion militare ci sta aspettando per portarci in caserma. Sono passati due giorni ed eccomi pronto per andare a Gemona dove un sarto di grido è addetto alla vestizione dell’ alpino del “Battaglione Tolmezzo 114ª Compagnia” comandata dal tenente Masetti. Si comincia con l’addestramento: prima si impara ad essere soldati, poi a diventare un buon mortaista, quale sarà la mia specialità. Vita di caserma per otto mesi fino al il 5 agosto 1942 giorno in cui siamo partiti con la tradotta per essere condotti a Rossosch. Il viaggio dura cinque giorni, giorni di tensione e timore. Rossosch.
Qui cominciamo a vedere quello che d’ora in poi sarà il nostro vero destino. Non ci fermiamo ma proseguiamo a piedi per altri quattro giorni fino ad arrivare al fronte sul Don in una località chiamata Saprina. Si comincia a combattere senza tanta foga; noi spariamo un colpo di mortaio e loro rispondono con sedici colpi di Katiuscia. Manteniamo però le nostre posizioni senza permettere l’avanzata del nemico. Sono passati quindici giorni di combattimenti senza avere subito grandi perdite quando arriva l’ordine di andare a rinforzare le due divisioni della fanteria “Cosseria” e “Ravenna” le quali non riescono a contrastare l’avanzata del nemico e si stanno ritirando. Arriviamo nella zona di combattimento al mattino presto; dopo un rapido aggiornamento partiamo all’attacco con foga e volontà ferrea e costringiamo i russi ad arretrare per 8 km fino a conquistare una collinetta che diventa per noi una piccola fortezza e dalla quale siamo in grado di dominare il campo di battaglia. I diversi attacchi dei russi al grido di “Urra” vengono da noi facilmente neutralizzati facendo con mortai e mitragliatrici diversi cadaveri. Mi trovo dentro uno dei tanti camminamenti da noi costruiti con il mio amico Giovanni Moruzzi, classe 1910 di Rugarlo di Bardi, quando una granata di Katiuscia cade fra di noi senza esplodere. Il mio amico dice: “Mario se riusciremo ad andare a casa faremo portare in processione la “Madonna della Canala” di Varsi. Con fare silenzioso si avvicina però l’alleato dei russi: la neve. Mi pare che sia anche più fredda di quella di Varsi. Mi dicono che non è vero, ma non ci credo. La neve si rivela un’arma famigliare ai russi, ma per noi è micidiale. Durante un momento di tranquillità, quando gli scontri si affievoliscono dando un po’ di respiro ai combattenti, gli alpini si scaldano attorno alla stufa; il silenzio viene però spezzato dal fragore di un ordigno che entra nel tubo della stufa ed esplode. Cinque alpini restano feriti in modo non grave mentre uno, Riccardo Curati di Varsi, mio fraterno amico, viene colpito in modo grave e tre schegge si conficcano nel braccio e due nella testa. Sapendo che sono dello stesso paese il tenente medico mi chiama e mi incarica di assisterlo. Da questo momento divento il sostegno di questo mio compaesano. Il nemico ottiene dei rinforzi, il freddo si fa intenso e la battaglia si fa sempre più cruenta. Il bianco campo di battaglia si “sporca“ di un numero sempre maggiore di alpini che soccombono alle fucilate. Ai morti ammazzati si aggiungono le vittime della “morte bianca” che penetra nei nostri indumenti non adatti a quelle temperature. Il nostro fronte regge ancora quando arriva l’ordine della ritirata: qui comincia la vera odissea. Carico Riccardo su di una slitta trainata dal mulo. Con la mano sinistra gli sorreggo la testa per evitare scossoni. La coltre bianca è sempre più alta, la temperatura sempre più fredda, la mia mano sempre più rigida, il male mi tormenta ma la testa di Riccardo poggia senza interruzione su quel cuscino anche se la sinistra si sta congelando. È pomeriggio: i russi incalzano furiosamente sostenuti anche dai partigiani. Vi è un fuggi fuggi generale e il mulo non corre più. A questo punto devo lasciare l’amico Riccardo, che mi saluta, sul posto con altri feriti. Addio! Un altro amico se ne và; tolgo il cuscino congelato dalla sua testa, lo adagio sul giaciglio bianco, gli copro il viso col suo glorioso cappello e lo saluto. Ciao! Molti feriti vengono abbandonati, in attesa di salire oltre le nuvole, su quel manto nevoso che diventerà per loro un bianco cimitero. Continuiamo intanto a ritirarci. Arriviamo in un villaggio e ci accingiamo a fermarci per riposare cercando riparo nelle misere abitazioni ove la popolazione, misera quanto noi, non può esserci di sostegno pur dimostrando grande rispetto nei nostri confronti. Nello stesso villaggio sosta una compagnia di Fanteria del Battaglione “Vicenza”. Un tenente chiede se fra di noi c’è uno che si chiama Ortalli. Mi presento e mi chiede di andare con lui. Timoroso lo seguo in un grande stanzone ove su un letto di paglia e fieno dormono i fanti. Mi indica un soldato. Io mi avvicino timidamente e giunto a breve distanza un nodo alla gola mi assale. Un fremito mi percorre tutta la schiena. La mano tremante corre sulle gambe del milite per svegliarlo con la paura che non sia realtà. È mio fratello Giuseppe. L’incontro dura poche ore. La sua compagnia deve partire immediatamente. Non l’ho più rivisto. È il settimo giorno della ritirata: ecco Nikolajewka! Qui è veramente il dramma, il dramma di tutti gli alpini. La disperazione, la voglia di tornare, la voglia di vivere, ci fa combattere con forze inimmaginabili anche se le forze in campo sono a nostro sfavore. In una chiesa sono tenuti prigionieri diversi alpini; con rapida e determinata azione riusciamo a sopraffare i russi e a liberare i nostri compagni. Un: “Mario” urlato mi fa sussultare. È Gino Eventi del Genio Alpino, mio compaesano, che gioisce per la liberazione. Sono uscito indenne da Nikolajewka, anche se con la mano congelata, e vengo destinato ad un ospedale militare. Mentre stiamo retrocedendo verso Rossosch la nostra colonna è presa di mira da una mitragliatrice che da una collinetta spara su di noi uccidendo molti alpini. Volontariamente mi propongo di far tacere la “mitraglia” pur avendo la mano congelata e senza arma. Corro allora verso la postazione, prendo il fucile di un alpino morto e mi scaglio con veemenza contro la postazione uccidendo il mitragliere e facendo prigionieri i suoi due compagni. Avendo anche i piedi assiderati chiedo al comandante che mi sia data la possibilità di indossare gli stivaletti di feltro con pelo caldo e morbido indossati dal russo. Gli stivali che mi hanno portato fino a Varsi. Ecco Rossosch. Da lì ero partito e lì sono tornato. Attendo una giornata il treno che mi conduce in Polonia dove mi viene visitata la mano sinistra; il tenente medico mi dice che la mano deve essere amputata. “Con due mani sono arrivato e con due mani io torno a casa” rispondo. Il tenente medico mi trasferisce per un ulteriore consulto all’Ospedale di Rimini ove arrivo dopo quattro giorni di tradotta. A Rimini vengo ricoverato e la diagnosi è la stessa; ma sono determinato e ripeto ai sanitari: “sono nato con due mani e morirò con due mani”. Rimango quaranta giorni all’ospedale militare di Rimini, detto colonia “Mussolini”, per essere curato e rimesso in forze. Ma la mano non guarisce. Vengo comunque dimesso e mandato a casa in licenza di convalescenza per quaranta giorni al termine dei quali devo presentarmi all’ospedale di Parma. A Parma il capitano medico Visconti mi amputa la prima falange dell’anulare e del medio; mi conferma che la mia testardaggine mi ha salvato la mano. Torno a Varsi e mi sento rinato. L’avventura è finita. Il 5 settembre 1944 con l’amico Giovanni Moruzzi decidiamo di andare al comando della resistenza a chiedere del bestiame per poter ricominciare la nostra attività contadina. Una pattuglia inglese comincia a mitragliare, noi cerchiamo riparo e protezione presso una casa ma una cannonata colpisce il fabbricato facendolo crollare sopra di noi. Sommersi dalle macerie veniamo soccorsi immediatamente. Il mio amico riporta ferite mortali, le mie sono invece di lieve entità. La buona sorte mi ha preso per mano ancora una volta mentre al mio amico ha girato le spalle. Dopo qualche tempo ho mantenuto fede a quanto avevo concordato con l’amico Giovanni: far portare in processione la “Madonna della Canala”. Questa è la mia storia. Questi invece i miei fratelli: Fiorenzo (classe 1912) alpino, campagna di Albania e Grecia. Giuseppe (classe 1915) fanteria, disperso in Russia. Nino (classe 1920) fanteria, Africa poi prigioniero in Inghilterra. Mario (classe 1921) alpino, Russia. Gino (classe 1924) artiglieria campale, prigioniero in Germania. Abbiamo dato a sufficienza?”
Onesto Melegari

Nasce il 28 ottobre 1923 a Gualtieri, un paese in provincia di Reggio Emilia, da una famiglia con 13 figli (6 maschi, di cui due prigionieri in Inghilterra e Kenya, e 7 femmine). Il padre, reduce della 1ª guerra mondiale, viste le enormi difficoltà nel provvedere al sostentamento di una famiglia così numerosa, decide nel 1934 di mandare uno dei figli, Onesto, che ai tempi aveva undici anni, a Roma dal fratello. “Salgo sul treno per la prima volta – racconta Onesto – e vado nella capitale a lavorare alla SAFAR (Società Anonima Fabbricazione Apparecchi Radiofonici) evitando anche la chiamata alla leva”. La guerra però incombe e a vent’anni, per non essere preso dai tedeschi, si nasconde entrando nella PAI (Polizia Africa Orientale Italiana) fino all’arrivo degli americani ad Anzio. Ritorna quindi a casa del fratello e, per guadagnare qualche lira, va a lavorare in campagna. “Successivamente esce un bando per arruolarsi…”. Lo mandano a Caserta e quindi a L’Aquila dove “il comandante è il colonnello Scarpa, di cui faccio l’attendente, ma ricordo bene anche il maggiore Giugliano Rasero”. A L’Aquila entra a far parte di un battaglione – il Gruppo di Combattimento Legnano – un gruppo di volontari formato sia da alpini che da bersaglieri che si uniscono agli inglesi per risalire l’Italia. Il viaggio è molto lungo e arrivati vicino a Bologna, e più precisamente al monte della Formiche, rischia di saltare in aria su una mina a filo. “Fortunatamente sono riuscito ad avvistarla e gli artificieri l’hanno fatta ‘brillare’.”
Arrivato a Parma riesce anche ad andare a trovare la famiglia “e questo grazie al colonnello Scarpa che chiese ad un soldato di accompagnarmi a Mezzani con una camionetta. A Chiozzola incontro anche mio padre che, dopo tutti quegli anni passati lontano da casa, nemmeno mi riconosce”. Riparte quindi per Aosta dove si scioglie il battaglione, “dopodichè sono ritornato a casa”. Della traversata di mezz’Italia Melegari ricorda “di aver fatto pochi prigionieri perché il nemico scappava, qualche morto a causa dei bombardamenti di ‘Pippo’, ed i tedeschi affogati attraversando il Po”. “Per fortuna – dice tirando un sospiro di sollievo – non ho mai avuto nessuno scontro a fuoco”. Finita la guerra gli è stato chiesto di rimanere nell’esercito ma non accetta. Trova quindi lavoro come tornitore e dopo qualche tempo conosce la sua futura moglie (Iva) durante un festival danzante nella ‘Casa del popolo’ di Sorbolo, ora caserma dei carabinieri. “Dopo poco ci siamo sposati e abbiamo avuto due figli (Rudy, alpino, e Angela). Tanti però sono ancora adesso gli episodi che Onesto non dimentica. A Roma, ad esempio, per non essere preso dai tedeschi, “mi sono nascosto in un pozzo usato dai carbonai. Con delle fascine mi sono poi calato in un fiume e sono scappato. Un altro avvenimento a cui ho preso parte è stata la rappresaglia a 100 civili italiani da parte tedesca a causa di una bomba lanciata da due partigiani in via Rasella, che ha causato dieci morti fra gli agenti della polizia tedesca; e come posso dimenticare quando mi sono ferito dopo una caduta a seguito dello spostamento d’aria causato da una bomba?”. Disavventure che, fortunatamente, Onesto Melegari non avrà più modo di fare.
Ugo Pellegrini

“Quanti anni sono passati dal quel giorno che il postino del paese mi ha consegnato un piccolo cartoncino colorato nel quale c’era un gentile invito a partecipare ad un raduno militare? Ora sono qui a raccontare quello che mi è successo. Ho deciso dopo tanto tempo di parlare della mia storia perchè avevo paura che la credessero solamente un racconto, ma poi ho pensato che quello che dirò potrà servire a chi ha velleità bellicose e a chi crede che si possa avere dei benefici con la violenza. Anno 1942, anni 20, destinazione 8° reggimento Alpini divisione “Julia” Battaglione Gemona 70ª compagnia. Arrivati a Gemona dopo un rapido addestramento eravamo pronti a sostituire gli alpini deceduti sulla nave “Galilea” silurata mentre ritornava dalla Grecia. Nella caserma di Tarcento ho avuto l’incarico di “conducente” e mi affidarono “Sconcio” (così era chiamato il mio locomotore) che diventerà un mio compagno inseparabile anche se al momento non ne ero entusiasta. Nel luglio 1942 avemmo la gradita sorpresa di fare una gita turistica in Russia e così a piedi ci recammo a Cormons dove l’8 agosto 1942 salimmo sul treno con destinazione Varsavia e da li, con zaino in spalla, ben coperti ma mal vestiti, sotto un sole cocente arrivammo il 28 agosto in Ucraina esattamente a Jsium. A questo punto il battaglione si divise; il comandante tenente colonnello Rinaldo Dall’Armi fu inviato a Rossosch a circa 300 km da Jsium mentre la mia compagnia, comandata dal capitano Chiussi, fu dislocata a Semeik sulle rive del Don dove restammo fino al 6 novembre vivendo un periodo abbastanza tranquillo.
Potevamo anche passare ore liete in riva al fiume, un corso d’acqua veramente notevole nel quale i pesci erano abbondanti e noi, nei pochi momenti di relax, cercavamo di improvvisarci pescatori anche perché l’appetito non scarseggiava. La popolazione era scarsa ma non indifferente, non era ostile, anche perché non so se eravamo più poveri noi o loro. Quando i primi freddi si fecero sentire ci spostarono a Wanowka e poi a Nowo Kalitwa per infoltire l’avanzata. Io ero sempre con il mio fedele compagno che, quando faceva veramente freddo, cercavo di abbracciare, non tanto per affetto quanto per necessità. Un giorno, mentre accudivo l’amico, un soldato russo si avvicinò di nascosto: con rapidità lo immobilizzai e lo feci prigioniero senza che opponesse resistenza. Mi consegnò, in segno di resa totale, cinghia, berretto e una piccola miccia che i russi usavano per danneggiare le bocche dei cannoni. Per questa operazione mi premiarono inviando ai miei famigliari una somma di 500 lire, che a quei tempi era ragguardevole. Venne dicembre, il freddo era veramente pungente, gli stracci che avevamo era pochi e ben poco confortevoli. Tenni gli scarpini per un intera settimana e quando li tolsi fu riscontrato dall’ufficiale medico il congelamento facendomi ritornare il Italia. Stetti 60 giorni all’ospedale militare di Piacenza per cure e convalescenza. In quel periodo ebbi la fortuna di ricevere la visita dei miei genitori ai quali era stato concesso il biglietto gratuito del treno. Dopo avere ripreso il vigore necessario fui rispedito al Reggimento dove trovai ad attendermi il mio locomotore “Sconcio” che mi salutò con una sgambettata. Ero a Attimis e da qui fui spedito sul Monte Pulfero per combattere la resistenza Jugoslava ma da dove, purtroppo, scendemmo con numerose perdite e feriti anche se quella non è stata una guerra cruenta e devastante come in Russia. La mia fortuna è stata quella di avere il mio “Sconcio” che in certi momenti mi è stato di riparo e anche di compagnia. Ritornati a Attimis ci vennero ritirati i muli e con un certo dispiacere lasciai il mio locomotore; dieci di noi furono fatti ritornare al quartiere generale di Udine con immensa gioia e senza rimpianto. L’unica tristezza è stata quella di lasciare amici e alpini destinati a soffrire e molti ancora a morire. Dopo l’8 settembre 1943 sono ritornato a casa da Udine a piedi in 13 giorni camminando di notte e mangiando quando potevo trovare una pianta da frutta o una famiglia premurosa e senza paura di ritorsioni. La felicità di essere arrivato a casa fu però di breve durata perché non è che si godesse di grande benessere tanto che fui costretto a seguire gli amici che si sacrificavano per un’Italia libera. Finita la guerra mi sono sposato con la mia Gelsomina, ho fatto l’agricoltore mentre durante l’inverno andavo a fare il conduttore di caldaie a carbone a Milano fino a quando ho potuto comprare una casetta ai Manini dove vivo una vecchiaia tranquilla. Scusate, non mi sono presentato, sono Pellegrini Ugo, nato a Matelloni di Varsi il 12/1/1922, reduce di Russia e figlio di Pellegrini Andrea, artigliere da montagna, reduce di guerra del 1915-’18”.
Pietro Turchi

Nato in località Masereto, nel comune di Solignano il 23 marzo 1916 e terzo di sette figli, è cresciuto nel paese natìo aiutando i genitori nella coltivazione dei campi e accudendo animali da stalla e da cortile. Arrivato il momento di svolgere il servizio militare Turchi è stato destinato nella Divisione Julia, 8° Reggimento, Battaglione Gemona, Compagnia Comando. “Da recluta – ci racconta – mi sembrava di essere in capo al mondo perché non ero mai andato lontano dalla mia provincia. All’inizio marcavo spesso visita nella speranza di poter ritornare a casa e per punizione mi facevano portare al poligono uno zaino pieno di cartucce”. Poi però lo hanno nominato addetto allo spaccio: “un luogo non adatto dove sparivano spesso dei generi alimentari anche da parte del mio ufficiale”. “Ricordo – prosegue con una lucidità invidiabile – di aver aggiunto dell’acqua alla damigiana del vino perché non potevo giustificare i prelievi; la stessa cosa l’aveva fatto anche il mio predecessore e il vino era ormai talmente annacquato che ho dovuto raccontare tutto all’Ufficiale di Picchetto, già avvisato dalle lamentele di diversi soldati”. Poi però, al congedo della classe del ’14, decisero di scegliere i sostituti per vari incarichi e Turchi fu in “bilico” fra un’ufficiale “che mi voleva come suo attendente e l’altro che mi voleva infermiere: alla fine l’ha spuntata quest’ultimo”.
La Guerra in Albania e Grecia
“A guerra iniziata sono stato richiamato alle armi con destinazione Albania e Grecia. Sono partito dall’aeroporto di Brindisi e atterrato a Valona”. È poi partito per il fronte per raggiungere i nostri che erano in ripiegamento sotto l’incalzare dell’offensiva greca. “Ricordo che prima di incontrare i nostri soldati abbiamo fatto tre giorni di marcia mangiando quel poco che riuscivamo a raccogliere dalle campagne. Durante la ritirata cercavo di medicare i feriti; in particolare ne ricordo uno che aveva una gamba fratturata e chiedeva aiuto; il sottotenente Rossi mi disse: “Non posso ordinarti di fermarti, non so cosa dirti, vedi tu”. Mi sono fermato e ho curato il ferito immobilizzandogli l’arto. Nel frattempo, essendomi attardato, ho perso il collegamento con gli altri. Ho cercato quindi di risalire una rupe ghiaiosa e, per non scivolare a valle, mi tenevo attaccato ad un cespuglio prima con le mani poi anche con i denti mentre mi sparavano addosso”. La fortuna ha voluto che mentre stava per saltare dentro ad un piccolo fossato “sono stato preceduto da un altro soldato che è stato subito dopo colpito a morte”. È stato fatto quindi prigioniero dai greci e portato insieme ad altri ad Atene. Arrivati, li hanno sistemati nella tribuna di un campo sportivo dove di notte “i civili greci cercavano di ucciderci”. Turchi ne ha passate davvero tante: “Abbiamo patito la fame cercando da mangiare fra i rifiuti. Eravamo anche infestati dai pidocchi e maltrattati dalle guardie albanesi che ci facevano anche inginocchiare sopra le nostre urine. Abbiamo cercato, ma invano, di scappare, anche se poi sono stati i tedeschi nostri alleati a liberarci”. Messo in “doppia” quarantena, Turchi è stato mandato in licenza per 30 giorni. “Quindi sono stato rispedito nel Friuli venendo a sapere che, durante la mia prigionia, il sottotenente Rossi aveva proposto al colonnello Pizzi – quest’ultimo era di Collecchio – di premiare la mia dedizione durante la ritirata con una medaglia d’argento. Il colonnello però, visto che non sapeva se ero vivo o morto, aveva rigettato la domanda”.
L’8 settembre 1943
“Quel giorno ero nella zona di Santa Lucia di Tolmino, una zona occupata dall’Italia ma contesa dagli Iugoslavi – prosegue a raccontare ‘l’infermiere’ – i partigiani di Tito avevano tagliato i fili del telelegrafo e il nostro comando aveva allora mandato tre autocarrette cariche di militari a riparare il guasto”. La fortuna fu ancora dalla pare di Turchi: “Dovevo andare pure io ma avendo finito il turno decisi di non partire. Mentre i miei commilitoni passavano in una gola furono bloccati dai partigiani “…dateci le armi perché per voi la guerra è finita” i nostri rifiutarono facendo nascere una battaglia durante la quale sono stati sopraffatti. Dalla caserma abbiamo sentito i rumori dello scontro e siamo partiti su tre camion per portar loro soccorso. All’arrivo abbiamo trovato le tre autocarrette che bruciavano. C’era solo un illeso (un sergente maggiore di Buia), gli altri erano tutti morti o feriti. Io medicavo alla luce del fuoco delle auto che bruciavano. I morti li abbiamo lasciati a Santa Lucia”. Sono quindi partiti su una corriera militare con i feriti a bordo “ricordo alcuni nomi: Pessina, Groppi”, verso Gorizia dove li hanno scaricati rimanendo alcuni giorni presso il magazzino del 9° alpini. “Il 16 settembre abbiamo deciso di abbandonare Gorizia per andare a Udine e chiedere ordini. Sono salito a bordo di un’autoambulanza con altri sei militari: due tenenti colonnelli, un tenente medico, un capitano e due autisti. Arrivati, gli ufficiali sono scesi per andare al comando di divisione: non si sono più visti”. “Nel frattempo alcuni civili friulani ci hanno portato dei vestiti borghesi. Siamo riusciti a scappare mescolandoci alla folla e ci siamo diretti a Tarcento dove ho trovato un altro alpino mio amico, Camerilli di Bazzano, che mi ha convinto a tornare a casa in treno”. I tedeschi erano ormai ex alleati e per sfuggir loro Turchi scendeva prima di arrivare in stazione. “Ricordo ancora che a Sant’Ilario d’Enza abbiamo visto due reclute in partenza per il fronte scendere per bere ed essere presi dai tedeschi e caricati su un treno bestiame diretto in Germania. Era impressionante vedere le persone stipate su questi vagoni in condizioni pietose che dicevano ‘abbiamo sete… sete’. Mi è andata bene: sono riuscito ad arrivare a casa”.
Fra la milizia e i tedeschi
“Io e mio fratello Attilio avevamo deciso di andare nei Partigiani perché rischiavamo di essere presi dalla milizia e spediti a Salò. Però i partigiani non avevano armi e allora abbiamo deciso di tornare a casa nostra. Per sfuggire ai tedeschi avevamo fatto un nascondiglio in una porcilaia; vi si accedeva solo dall’alto sollevando la pavimentazione di una vecchia cucina. Non c’era luce e dovevamo fare i nostri bisogni dentro un grosso secchio. Inoltre i tedeschi avevano istituito il loro comando proprio nella stanza sopra di noi. Eravamo in sette ed uno aveva una forte tosse; quando cominciava a tossire lo isolavamo con due cuscini, per evitare che lo sentissero”. Poi i tedeschi si sono ritirati, la guerra è finita e Turchi si è rifatto una vita non scordando però quei terribili anni.
Luigi Venusti

Luigi Venusti è nato a Canesano, piccolo gruppo di case nel Comune di Calestano, il 9 luglio 1921. Con il fratello e i genitori ha condotto una vita di tribolazioni lavorando nei campi e allevando bestiame. Dopo aver frequentato la scuola del paese, dove allora c’erano molti più ragazzi di adesso, è partito militare il 12 gennaio 1941 venendo arruolato nel battaglione “Gemona” della Julia. Appena il tempo di giurare fedeltà e viene mandato a fare servizio di guardia con altri 29 compagni sul confine italo-iugoslavo. Rientrato in caserma a Udine vive in baracche di legno; ha un attacco acuto di peritonite e, come Venusti ricorda ancora benissimo, viene operato il 26 luglio 1941 nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Per questo usufruisce di una convalescenza di un mese e ritorna a Canesano in famiglia. Tornato a Udine, ma non ancora ben ristabilito, viene nominato attendente del maggiore Francesco Alagna. Ricordandosi delle sue attività di ragazzo, e conosciuto un missionario, si presta a fare il chierichetto e il campanaro conquistandosi la simpatia e l’amicizia del sacerdote. Un giorno, ed è un episodio impresso nella memoria di “Gigi”, il capitano chiama a rapporto il “campanaro” e visto che aveva i capelli un po’ lunghi, gli infligge cinque giorni di consegna.
Ma ecco che il missionario, conosciute le grandi doti e la disponibilità di Venusti, interviene presso il superiore e non solo riesce a togliere la punizione ma, come ringraziamento per il lavoro svolto, riesce a fargli concedere una licenza premio di 5 giorni + 2. Dopo la licenza succede un po’ di tutto, e non sempre cose lieti. Viene mandato con il battaglione nel Montenegro in piena guerra: viene ferito più volte alle gambe e una pallottola gli passa da parte a parte la faccia asportandogli alcuni denti. È in Grecia e ricorda un altro episodio particolare legato al naufragio del “Galilea”. Mentre viene fatto scendere dal piroscafo, evitando così guai peggiori, ricorda di aver conosciuto un certo Otello Ghillani, classe 1921 come lui, poi naufrago, che rincontrerà a casa, ferito e in condizioni mentali pessime. Arriva finalmente l’8 settembre, la guerra è finita ma Venusti e il battaglione rimangono incastrati fra i partigiani e i tedeschi. Il loro comandante, un certo Borca, con un po’ di diplomazia e soprattutto con grande coraggio, riesce a strappare un lascia passare ai tedeschi e un po’ in treno, ma molto tempo a piedi, riescono ad arrivare alla frontiera. In una caserma di confine vengono rifocillati alle meglio e riprendono il cammino fino a Udine. Ormai sbandati ognuno va per la propria strada. Venusti la sera del 12 settembre 1943 arriva a Amoretto di Tomba, un piccolo paesino dove un ragazzo lo porta in casa e lo sfama. Di nuovo a piedi raggiunge la provincia di Parma passando prima a Traversetolo, poi a Sala Baganza dove riesce a salire sul tram che lo porterà a Marzolara. Particolare curioso: Venusti non aveva soldi per pagare il biglietto ma come ricorda ancora molto bene, l’autista, un certo Artemio, visto in che condizioni era, lo fa salire ugualmente. Venusti ricorda però che i soldi non gli erano mai mancati perché aveva avuto anche un premio di 50 lire per buona condotta. Le peripezie non erano ancora finite. A casa riprende la vita normale: contadino, muratore, carpentiere passando pure un anno da immigrato in Svizzera. Fa anche il norcino girando di casa in casa e facendo amicizia con tutti. Tenta la via della pensione per le ferite e per l’intervento subito all’Ospedale ma non riesce ad arrivare ad alcun risultato e questo lo lascia ancora oggi insoddisfatto: alla Patria ha dato tanto ma come molti suoi compagni ha avuto poco in cambio. Dal Gruppo Alpini di Calestano, con una cerimonia toccante durante la quale gli è stata consegna la pergamena di “reduce”, ha ricevuto all’inizio dell’anno il riconoscimento del servizio fatto. Ora Venusti vive con la famiglia a Canesano con un chiaro ricordo del militare e quando la salute glielo permette prende parte attiva alla vita del gruppo di Calestano al quale fin dall’inizio è iscritto
Attilio Franceschini

Franceschini Attilio nasce a Pagazzano, piccolo agglomerato di case nel Comune di Berceto, il 20 aprile 1922 in una famiglia di modesti contadini. Inizia le scuole nella frazione e nel tempo libero porta al pascolo le poche mucche e qualche capra cercando di vivere dignitosamente anche se spesso si soffriva la fame. In seguito si trasferisce a Selva Grossa nel Comune di Terenzo dove la famiglia conduceva a mezzadria un piccolo podere a Case Cadoppio. Franceschini ricorda perfettamente di essere partito militare il 25 gennaio 1942 lasciando a casa il padre (la mamma era morta da tempo) e ben nove fratelli. Arruolato nel battaglione “Gemona” passa i primi quattro mesi in caserma a Tarcento. Arriva però il triste giorno: l’8 agosto 1942 da Udine, in tradotta con tanti altri alpini, parte per il fronte russo. Lunghe marce, continui spostamenti, freddo intenso e la fame che la fa da padrona, e così sino alle rive del Don. Sul fronte la cruda realtà di tutti gli alpini: lotta impari, freddo polare, amici che muoiono vicino senza un conforto e la voglia di far ritorno a casa attendendo spesso, ma invano, notizie dalla famiglia lontana. I momenti più tristi sono al calare della sera quando stringe al petto i pochi ricordi personali e di famiglia portati con sé. Franceschini vede uno alla volta tanti alpini soccombere nella neve soffocati, molto spesso, dalla fame e dal freddo più che dalle armi nemiche. Anche lui come tanti altri rimane congelato ai piedi (ancora adesso ne subisce le conseguenze e il suo incedere è purtroppo lento e faticoso), viene ricoverato all’ospedale sul fronte dove deve anche curarsi dai pidocchi. La fortuna sembra però sorridergli. Dopo essere scampato dall’inferno russo conosce in ospedale un capitano alpino originario di Modena il quale lo manda a casa in convalescenza. Attraversata la Germania tra mille difficoltà e paure arriva a Bologna.
Da qui un po’ in treno e con mezzi di fortuna giunge a Fornovo dove nel frattempo si era trasferita la famiglia e a casa passa un breve periodo di convalescenza. Finita la convalescenza Franceschini deve rientrare al corpo a Tricesimo di Udine; passa un breve periodo a Gorizia e quindi rientra a Tarcento alla sede del battaglione “Gemona”. Qui si sparge la notizia che la guerra è finita – 8 settembre – e nonostante i superiori cerchino di tenere nascosta la notizia, avviene un fuggifuggi generale e tutti cercano di mettersi sulla via del ritorno a casa. Franceschini, allora caporalmaggiore capofuciliere, si mette in cammino ma viene intercettato da una pattuglia in servizio e fatto rientrare in caserma. Pensava che la libertà fosse ancora lontana e che potesse essere di nuovo mandato a combattere in un esercito che ormai era allo sbando. La fortuna ancora una volta lo favorisce: di notte riesce a fuggire dalla caserma con altri compagni e finalmente, in abiti borghesi (glieli aveva procurati una famiglia di Melzi dove aveva alloggiato la prima notte dopo la fuga) si avvia verso Fornovo dove arriva il 16 agosto 1944 con il timore di essere catturato dai tedeschi in ritirata e spedito in campo di concentramento. Al paese non trova più gli amici di una volta perché molti sono stati deportati in Germania. Anche il fratello è stato deportato ma riuscirà ad abbracciarlo quando miracolosamente rientrerà dopo un po’ di tempo. Gli occhi lucidi e la voce fioca fanno ancora trasparire questa gioia e Franceschini, nonostante l’età e qualche malanno fisico rimediato in Russia, è ancora sorridente quando passa qualche momento con gli amici ricordando soprattutto gli aspetti positivi della sua disavventura al fronte con un pensiero, però, anche ai tanti amici che non sono mai più ritornati.
Gino Saracchi

Saracchi Gino, del gruppo di Colorno, così ci racconta il suo lungo calvario durante il ripiegamento degli Alpini dal fronte russo, mentre la sorella Lucia ascolta, si immedesima e si commuove ancora, rivivendo nelle sue parole le sofferenze del fratello e l’angoscia della famiglia che lo attendeva e stava in pena per lui.
“La strada”….. chiamavamo così quella interminabile serie di piste, viottoli e carraie che abbiamo percorso noi italiani, da quando iniziammo la terribile ritirata, nel gennaio 1943. Laceri, stanchi, feriti e congelati percorremmo a piedi centinaia e centinaia di chilometri in terra russa. Gli occhi si chiudevano pel sonno, le gambe ci si piegavano sotto, i piedi trasudavano il pus ed il cuore era oppresso da uno sgomento indicibile. Soldati ed ufficiali sbandati formavano una immensa processione nerastra. Ogni tanto qualcuno si fermava e non si rialzava più… le lacrime ci scendevano brucianti dagli occhi e si perdevano fra la barba, qualcuna ci arrivava alle labbra e ci pareva di non aver mai sentito nulla di più amaro. Tristezza, squallore, neve, chilometri e chilometri di strada senza una casa, senza un tetto, senza una pianta. “Come mi è grande questa Russia” pensavo... così grande non mi era sembrata quando vi ero giunto… ora mi pareva che il mondo fosse tutto così e che non sarebbe finito mai e stringevo i denti per non piangere. Pensate che allora non avevo ancora vent’anni.
La testa grigia del capitano che avevo accanto mi faceva pena e sopportavo ancora di più per lui che per me. A casa in Italia mi aspettavano le tre persone care che mi erano rimaste: la fidanzata, una sorella, il nonno. Pensavo a loro… e la strada non finiva mai. A volte mi pareva che anche dopo essere arrivato avrei continuato a camminare per forza di inerzia. E i piedi mi dolevano atrocemente: le pezze che li avvolgevano non avevano più colore e dalle loro fasciature filtrava il sangue marcio che lasciava una scia sul terreno. Poveri noi, poveri tutti. Quando ci si fermava era peggio; riprendere la marcia era una fatica sovrumana. Sognavamo ad occhi aperti il nostro tetto e ci pareva una cosa irraggiungibile: fra noi e il letto migliaia di chilometri di strada: Bielgorod… Karkov ora sembrano nomi di fantasmi, nomi di città mai viste eppure son passato fra voi ed ho pianto di rabbia, senza lacrime, col cuore che mi scoppiava. La neve tutta calpestata da migliaia di piedi era diventata qualcosa di schifoso che dava nausea, le gibbosità dell’orizzonte (le famose montagne russe) ci facevano girare la testa, i pochi alberi striminziti ci ricordavano più intensamente i pioppi alti e dritti sulle rive erose dei nostri piccoli e chiari fiumi. Il pioppo altissimo vicino alla mia povera casetta mi appariva laggiù lontano fra la bruma fitta e fredda e mi pareva che sulla sua chioma tremula ci fosse la scala per salire in Paradiso. Ogni poco passavano con rumore assordante le autocarrette dei nostri “cari” amici tedeschi e con la rapidità del fulmine vedevamo sfilare facce feroci, volti istupiditi, capelli biondastri ritti come per la paura e una notizia circolava allora lungo le nostre file – ragazzi, arrivano i Russi! – e uno spavento indicibile ci agghiacciava la mente. Non era tanto la paura dei Russi, che avevamo conosciuti, ma la terribile paura di non ritornare più a casa: un nodo ci afferrava la gola, un nodo che non andava giù e guardavamo la strada con occhio bieco, con odio profondo… sapeste quanto ho odiato la strada! A Karkov non ne potevo più: ormai le mie facoltà mentali erano alterate, la fame, la sete, il freddo i dolori acuti ai piedi morsi dal gelo mi facevano delirare. I lamenti dei compagni esausti, l’agonia e la morte sempre vicine facevano vacillare la mia povera testa. Non speravo più, non sapevo più nulla. Mi sedetti con le spalle al muro e restai inebetito con le mie povere labbra secche aperte e gli occhi semichiusi. Quella che era stata la mia divisa di Alpino non era più che un cencio lurido e pieno di pidocchi, non avevo più il berretto e non avevo più la pelliccia: ero un mucchio di stracci sull’orlo della strada. Una camionetta passò e mi raccolsero: Brest Litowski, il Lazaret, le prime cure e poi il treno ospedale e finalmente la pacchia, il sollievo immenso di sapere che tutto era finito. Allora benedissi quella strada che prima avevo maledetto ad ogni passo, perché mi aveva riportato a casa.
Luigi Dallaturca e Enrico Gennari

Dallaturca Luigi nato il 7.10.1915 del battaglione Tolmezzo, partito per il servizio nel 1935 destinazione Tolmezzo, in Carnia. Dopo essere rimasto 18 mesi, fu congedato nel 1936 e quindi richiamato nel 1939 e inviato sul fronte greco-albanese e la rimase fino al 1941. Un ricordo particolare: per alcuni mesi, visto che aveva imparato il mestiere da ragazzo nel suo paese, è stato il barbiere del beato Don Carlo Gnocchi. Congedato alla fine del 1942, ritorno’ al suo paese natale dove riprese la sua attività come contadino.
Gennari Enrico nato nel 1922 pure lui del battaglione Tolmezzo, partito per la leva nel 1942 e destinato in Russia dove arrivo’ il 12 luglio 1942, precisamente nella cittadina di Isio. Arrivo’ quindi sino a Stalingrado e qui come tanti altri nostri alpini conobbe il freddo, il gelo, la fame e tutti i disagi della ritirata. Ricoverato in ospedale, conobbe una infermiera originaria di Chiavari e finalmente riuscì ad arrivare in Italia, all’ospedale militare di Imola.
Qui rimase per un lungo periodo e finalmente il 2 giugno 1943 pote’ fare ritorno a casa. Nella foto i due alpini compaesani, felici di poter ancora brindare insieme, nel ricordarci tuttavia i grandi valori di cui furono portatori nella loro cruda ma vera realtà della guerra: amore di patria, attaccamento alla famiglia, coraggio, amicizia e compimento fino alla fine del proprio dovere.
Bruno Sanelli

Sono nato a “Case Trolli” nel Comune di Medesano il 15 ottobre 1913. Questa località dove i miei nonni risiedevano fin dal 1880, vide i natali anche di mio padre, nel 1884, e dei miei fratelli. La mia famiglia rimase lì fino al 1933, anno in cui ci trasferimmo a “Costa Garibaldi”, sempre a Medesano. Il 6 aprile del 1933 fui chiamato alle armi a Tarvisio , dove trascorsi 11 mesi ed altri 12 li passai a Chiusaforte. In quel periodo vidi partire molti compagni per l’Africa ma per il mio contingente, invece, arrivò uno strano ordine che prevedeva il rientro a casa per quanti fossero stati in possesso di abiti civili. Riuscii a farmi inviare da casa il necessario, ma invece del congedo, inaspettato arrivò l’ordine di trasferimento a Tarcento.
Zaino in spalla e valigia alla mano, passando per Moggio, Carnia, Venzone, Gemona ed Artegna, giungemmo a piedi a destinazione. Fra ordini e contrordini, fasi concitate e momenti più tranquilli (non prima di avere fatto 4 campi), ottenni infine il congedo il 4 aprile 1936. Nella primavera di quell’anno venne richiamato alle armi mio fratello più grande, classe 1912, ed inviato in Albania. Dopo pochi giorni giunse anche il mio turno, ma con destinazione Udine, aggregato all’8ª Sezione Sanità. Rientrando a casa per una breve licenza “agricola”, ebbi la gradita sorpresa di scoprire che mia cognata aveva dato alla luce il primogenito Armando. Dopo un fallito tentativo presso i Carabinieri di prolungare la licenza, tornai a Udine dove alla metà di settembre ci raggiunse l’ordine di partenza per l’Albania. Il 29 settembre 1939 il piroscafo ci traghettò fino al porto di Durazzo e da lì, con i camion, fummo subito trasferiti a Pukor per dare il cambio ai “vèci” della classe 1910 ormai esausti. Trascorsi quella notte in una tenda con mio fratello, che la mattina successiva rientrava in Patria. Alzati di buon mattino, col mio compagno Navarini ed altri 4 parmigiani, piantammo la nostra tenda presso quella del tenente Magnani che, di ritorno dalla mensa ufficiali, ogni sera ci allungava un fiasco di Chianti con l’ordine perentorio, da noi però molto gradito, di cantare. Arrivò Natale e con esso la licenza illimitata. Nel febbraio del 1940 però fu chiamato alle armi mio fratello Dino, il più giovane di noi non ancora ventenne, ed inviato anch’egli in Albania a Scutari col Battaglione Gemona. A giugno del 1940 venni nuovamente richiamato a Udine ed inserito nel neonato 28° Reparto Salmerie, col quale fummo destinati anche noi in Albania e giunto a Scutari rividi, finalmente dopo mesi, mio fratello Dino. Il caldo insopportabile, la mancanza d’acqua nel fiume Drin per noi ed i muli, indusse il Comando a trasferire l’accampamento a Puka, dove restammo fino al 28 ottobre. Verso la mezzanotte di quel giorno, la 69ª Comp. del Btg. Gemona sferrò un duro attacco ad una casermetta greca posta a presidio della zona. L’8° Reggimento alpini, sotto una violenta pioggia, entrò così in territorio nemico dal “Cippo 7”, purtroppo però con i primi alpini feriti. Il violento contrattacco dei greci alla nostra retroguardia colpì le salmerie, con vittime fra i conducenti ed i muli. Anche il tenente Magnani venne ferito nello scontro e noi delle salmerie lo incrociammo mentre veniva portato nelle retrovie per le cure del caso. L’insistente pioggia rese le mulattiere impraticabili dal mare di fango, aggiungendosi così al problema di essere stati accerchiati dai greci. Per 11 giorni fummo riforniti di viveri e munizioni solo dagli aerei. Durante uno di questi lanci una cassa, purtroppo, cadde sopra l’accampamento uccidendo un carabiniere in una tenda. Aggregato alla 70ª Compagnia del Btg. Gemona, dopo essere rimasto senza il fedele mulo, con la mia squadra fui comandato a protezione di un ponte su cui sarebbero passati i nostri reparti. Subito dopo il passaggio del “Gemona”, del “Tolmezzo” e del “Cividale”, fummo investiti da violento attacco di truppe greche, trovando infine salvezza e riparo in un profondo canalone. Minacciati di accerchiamento, nonostante la nostra resistenza, fummo salvati dall’intervento del Btg. L’Aquila. Il 28 e 29 novembre resistemmo dall’alto di roccioni alla pressione greca su un fronte che si snodava per più di 1 Km; sulla sinistra purtroppo il Btg. L’Aquila, già stremato dal lungoperiodo trascorso in prima linea, cedette costringendoci a ripiegare. Durante la manovra una bomba di mortaio nemica colpì la postazione delle mitragliatrici pesanti uccidendo il nipote del mio compagno Navarini e tre suoi compagni. Dopo tre mesi di prima linea, senza tregua nei combattimenti né riposo, il 28 gennaio 1941 il cambio mi permise di rientrare al 28° Reparto Salmerie. Causa il mancato arrivo dei muli da Brindisi, fummo urgentemente spediti a Tepeleni per caricare negli zaini 4 bombe da mortaio a testa e portare quel pesante e pericoloso carico alle prime linee, camminando ininterrottamente per più di 5 ore. Col tempo giunsero dall’Italia anche i fedeli ed indispensabili muli con i quali ci attendammo sulla riva del fiume Vojussa, da dove ogni sera si partiva con i rifornimenti per la prima linea, attraversando il ponte di Dragoti sulla Vojussa (uno dei momenti più critici, anche i muli fiutavano il pericolo e attraversavano il ponte di corsa) e salendo per ore verso i pericolosi monti greci. In quel periodo mio fratello Dino, postino e portaordini del Battaglione Gemona, fu ferito di striscio ad una spalla da una scheggia di granata mentre andava a prelevare la posta a Tepeleni. Dopo tanto strazio e tanta fatica, fra alti e bassi, giunse la fine della guerra greco-albanese e sfilammo per le vie di Atene. Il mese successivo fummo inviati a presidiare il Canale di Corinto. Durante un trasferimento al termine del presidio, ci imbattemmo a Lutraki nel Btg. Gemona in procinto d’imbarcarsi per il definitivo rientro in Patria. Purtroppo la maggior parte di questi alpini non raggiunse mai l’Italia perché la notte del 28 marzo 1941 un sommergibile inglese silurò il piroscafo “Galilea” sul quale erano imbarcati e lì, insieme a tanti compagni ed amici, trovò la morte anche mio fratello Dino. Il giorno successivo alla tragedia, fummo inviati in tutta fretta a Corinto per prelevare i muli del Btg. Gemona che, imbarcati su un altro piroscafo che non era salpato assieme alla nave “Galilea”, erano rimasti senza conducenti. Ci rimettemmo in marcia, ognuno con due muli al seguito, verso Patrasso. Da qui, alla fine di aprile, partimmo in treno con destinazione: Italia! A Postumia trascorremmo il previsto periodo di “contumacia”, al termine del quale, finalmente, ci fu concesso un mese di licenza. Ma la mia naia non finì così... .la Grecia è terminata, a Udin siam tornati e tosto per la Russia noi siamo destinati... Il 15 gennaio mentre siamo in attesa di bere un caffè caldo, arrivò di corsa il tenete Venuti di Udine gridando: “…c’è il trombettiere?”, trovatolo fece suonare immediatamente l’adunata e gelando tutti, se ciò fosse stato ancora possibile, annunciò: “Siamo accerchiati, ribaltate le marmitte e caricate in fretta le slitte”… poi rivolto al cuciniere chiese: “quanto segna il termometro?” e l’altro: “- 41° tenente”. Attraversammo Rossosch ed il termometro della stazione segnava -42°; la sera giungemmo a Podgornoje in mezzo alla tormenta con -45°e senza potersi fermare, l’ordine è infatti di proseguire non appena alleggerite le slitte per caricarvi i feriti e i congelati. Morini di Berceto che a Tavagnacco era il sellaio del reparto, prima di partire per la Russia, andò ad Udine a prendere il cuoio col quale confezionò due paia di scarponi ‘doppi’. Quando me ne offrì un paio fui lieto e grato di accettarlo e lo sono ancora oggi, quegli scarponi infatti mi salvarono i piedi dal congelamento, purtroppo non fu altrettanto fortunato lui che non fece più ritorno a Berceto. La nostra colonna non procedeva con il grosso della Tridentina ma comunque con parte di essa che, ancora ben armata si pose alla testa del ‘serpentone umano’ e noi subito dietro con le slitte per raccogliere quanti più possibile di coloro che, congelati o feriti cadevano lungo il cammino. Camminammo per 17 giorni in condizioni critiche di fame e freddo, ben sapendo di essere accerchiati e subendo continui attacchi da parte delle truppe regolari e dei partigiani russi. Il 31 gennaio ebbe luogo un feroce combattimento che durò per l’intera giornata, le nocciole del bosco erano macinate dalle cannonate e dalle raffiche delle mitragliatrici. La notte, col favore del buio, ci rimettemmo in cammino ed 1° febbraio verso le 22 giungemmo ad Olichowatka; qui trovammo riparo in un’isba e finalmente non si sentiva più sparare. Il mattino seguente arrivò un treno con 4/5 carrozze sulle quali caricammo i feriti più gravi, io ne lasciai su quel treno solo due di quanti ne avevo sulla slitta. Il capotreno chiese se qualcuno desiderasse far giungere notizie a casa, …ma in fretta…. non era infatti possibile ritardare la partenza del convoglio. Corsi nell’isba e strappai con la baionetta un pezzo di carta da formaggio e, su quell’iprovvisato biglietto scrissi:” “Sono fuori pericolo, sto bene”. Al mio rientro a casa seppi che il postino di Gaiano, veterano della Grande Guerra, quando recapitò il ‘biglietto’ a mia madre, si commosse alle lacrime sapendo che ella aveva già perso un figlio nel naufragio del piroscafo Galilea, uno era in Russia ed il più grande, sempre alpino, scortava i treni che dal Friuli attraverso i territori occupati dai partigiani di Tito, andavano in Grecia. Lasciammo Olichowatka e lungo la strada incontrammo le slitte del battaglione Gemona, Bertinelli sulla sua trasportava 11 uomini fra feriti e congelati; incontrammo anche Dodi di Varano il quale salvatosi in Grecia, tornò anche dalla Russia per poi esser ucciso a due passi da casa. Giunti a Belgorod trovammo un secondo convoglio composto da 7/8 carrozze, vi caricammo tutti i feriti e i congelati rimasti sulle slitte, svuotandole. Concluso il nostro ingrato compito di ‘traghettatori’, arrivò un camion della sussistenza carico di viveri fra i quali non passarono inosservati due barilotti di cognac ed uno di anice, qualcuno sparò sulle botti e subito… tutti sotto con gavette e borracce. Fui costretto a dividermi dal mio compagno di slitta il quale, a causa del congelamento ad un piede salì anch’egli sul treno; noi rimasti proseguimmo la marcia verso Gomel dove giungemmo l’11 marzo 1943 e lì finalmente salimmo sulla tradotta che ci ricondusse attraverso il Brennero a Vipiteno. Il battaglione Gemona fu spostato a Colle Isarco per il consueto periodo di contumacia, al termine del quale tornò verso Udine e precisamente a Tricesimo. Da Tricesimo, fummo successivamente mandati a Caporetto, poi a Castelmonte, poco sopra Cividale, e l’8 settembre di nuovo a Caporetto. Il giorno 9 settembre i tedeschi giunsero a Tarvisio, e noi fummo divisi, una metà fu inviata a Cave del Predil e l’altra, fra cui io, a Plesso. Arrivati a Plesso, siccome i tedeschi giungevano anche da Tolmino, già dal giorno 10 tornammo sui nostri passi. Al comando del capitano Gasparini che sostituì il tenete Venuti rimpatriato a causa di congelamento, in 22 ci appostammo su di un’altura ad un chilometro da Caporetto con due nidi di mitragliatrici. Qualche giorno dopo fummo visitati da un maggiore proveniente da Udine al quale il Capitano chiese quali ordini ci fossero per noi, il maggiore rispose: “non sparate”… il capitano infuriato replicò: “allora cosa ci stiamo a fare qui, i fessi?... se ne vada, o giro la mitragliatrice e la faccio a pezzi”. Nascosto in un bosco poco distante c’era il carro trainato dai muli sul quale caricammo le armi e scendemmo verso il paese. Raggiunto Caporetto vedemmo che la sussistenza stava caricando un camion con rimorchio e da sopra la sponda di questo si vedevano delle invitanti forme di formaggio; avvicinammo il carro e ve ne facemmo scivolare sopra 3. Il capitano allora, ordinò di allontanarsi velocemente prima di essere visti e, con ‘circospezione’ ci avviammo verso Cividale. Lungo la strada ci fermammo in un’osteria dove il capitano Gasparini ordinò tre boccali di vino, poi chiese all’oste un coltello robusto adatto a fare a pezzi le forme di formaggio. Ne consegno una punta a testa ed i rimanenti 3 kg, circa, li donò all’oste che contento di accettarli non volle nulla per il vino servito. Il mattino seguente a Cividale ci rifornimmo di pane e inaspettatamente il capitano ci congedò dicendo: “Io non posso tornare a casa perché abito in città a Trieste ed è in mano nemica, quindi mi unirò ai partigiani, voi andate ma, mi raccomando: non fatevi sparare”. Qui finisce la storia di naia dell’alpino Bruno Sanelli, se qualcuno volesse conoscere cosa gli è successo negli ultimi 67 anni trascorsi da allora, lo può trovare nella baita del gruppo di Medesano o a molte manifestazione alpine della nostra provincia. Consentite però a chi ha raccolto questa testimonianza di ringraziare Bruno, come feci quando lo conobbi, per esserci stato allora ma soprattutto per avere scelto di rimanere, anche dopo quanto ha passato, ancora con noi oggi! Grazie Brunè per aver saputo fare esperienza anche di quei brutti momenti e di averli saputi trasformare in un insegnamento per riuscire ad apprezzare ogni attimo della vita, ma ancor di più perché riesci a trasmettere questa vitalità e questa gioia di vivere a chiunque ti stia vicino. Senza alcuna retorica, ma con grande affetto!
Alessandro Armani

Le storie dei nostri reduci sembrano tutte uguali, ma sono tutte diverse, per le sensazioni personali, le difficoltà e il carattere che cambiano il corso degli eventi. Alessandro Armani classe 1921, bercetese di Fugazzolo figlio di un artigliere che aveva combattuto la Prima Guerra Mondiale, non ha voluto essere da meno del padre e nel gennaio 1941 ha risposto alla chiamata alle armi per la Seconda. Ci racconta volentieri di quando fu destinato alla Compagnia Comando della Julia, con la quale ha partecipato alle operazioni in Grecia e in Albania e alla campagna di Russia. Partito da Gemona dopo un breve addestramento, gli venne assegnato l’incarico di conducente, che avrebbe poi ricoperto per tutta la ferma militare. Dopo una breve incursione in Jugoslavia e una sosta di pochi mesi a Tarvisio, venne inviato in Grecia con il compito di trasporto viveri ai reparti e qui conobbe la prima linea, anche se non da combattente ma percorrendo vie e sentieri sotto l’accompagnamento della sinistra musica delle armi. La permanenza in Grecia fu dura, anche se alleviata dalla confortante presenza di compaesani. Al momento di rientrare in Italia, consegnato a malincuore il mulo ai rincalzi della Milizia Italia, lo aiutò una prima buona stella, anche se al momento non sembrava tale: arrivato in ritardo per imbarcarsi sul il piroscafo Galilea, fu costretto a rientrare in Italia in treno attraverso la Jugoslavia.
Solamente dopo l’arrivo avrebbe saputo del tragico naufragio della nave e della buona stella che lo aveva salvato. Rientrato a Udine dalla in licenza di 30 giorni, la recondita speranza di non dover ripartire fu delusa nel modo più amaro e venne inviato al fronte russo. Compagno di sempre l’amico mulo, che divenne il silenzioso confidente dei suoi pensieri più intimi e che lo rese benvoluto tra i commilitoni, che attendevano con ansia e con fame la posta e i viveri che portava. Inattesa, la seconda buona stella si presentò con il dolore lancinante della frattura di una gamba. Ricoverato in diversi ospedali da campo prima di essere trasferito in un ospedale militare in Polonia, pur nella sofferenza si sentiva molto più fortunato di quelli che nella steppa innevata avevano dovuto subire gli orrori della ritirata. Nel 1943, dall’ospedale polacco venne trasferito all’ospedale militare di Riccione dove finalmente le cure e l’aria di casa ebbero il loro effetto. Convalescenza di pochi giorni e di nuovo al reggimento, che per fortuna sarebbe rimasto in sede fino al fatidico 8 settembre. Dopo lo sbandamento dei reparti all’armistizio, un lungo viaggio, su mezzi di fortuna e a piedi attraverso campi, boschi e paesi, lo portò fino a Berceto, ove giunse tanto provato che i parenti dapprima non lo riconobbero. Alla fine del racconto, Armani ci tiene ad affermare con enfasi: “sono un Alpino e sono orgoglioso di esserlo. W la Julia!”